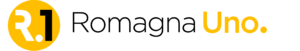Stavolta ho giocato in casa, nei luoghi così cari della mia infanzia e della mia vita da adulta.
Quassù, a Perticara di Novafeltria, dove mio nonno Luigi Farneti ha costruito la sua famiglia, dove la miniera di zolfo lo ha visto patire per 25 anni negli abissi della terra, dove negli anni del boom economico italiano ha fatto fagotto e con moglie e figli è emigrato, non lontano, a Cesena, dove sono nata io.
Sono molto legata a questo territorio, quasi come alla mia Cesena. Parte delle mie origini sono qui, mi sento radicata.
Domenica 27 maggio c’è stata una camminata organizzata dallo Spaccio della Miniera (gestito dalla Cooperativa Agricola dell’Alta Valmarecchia), in occasione dell’evento Fattorie Aperte.
Il mio amico scrittore e fotografo Ido Rinaldi, insieme agli altri instancabili camminatori di Perticara (Fernando, professore di matematica ed esperto negli esperimenti di chimica e fisica legati allo zolfo; Roberto fotografo; Paolo guida al gruppo di escursionisti) hanno studiato un percorso per far conoscere i luoghi meno recenti della storia della miniera di zolfo di Perticara. Hanno sperimentato il giorno prima il percorso e, con l’aiuto dei dipendenti dello Spaccio, hanno pulito i sentieri per rendere agevole la nostra camminata.
Il nostro nutrito gruppo di camminatori, più di 50, fra i quali anche una decina di turisti provenienti dalla Danimarca si è avviato, dopo le nove del mattino.
Prima di imboccare i sentieri, Pierluigi Draghi e la moglie Luisella (titolari della cooperativa), ci hanno mostrato l’allevamento di bovini dell’Alta Valmarecchia. Queste stalle si trovano proprio dietro al museo della miniera di zolfo Sulphur.
Da qui, abbiamo preso il sentiero che passa di fronte ai calcaroni. Si tratta di forni di fusione dello zolfo, nel quale il minerale veniva separato dalle impurità. Malgrado siano passati più di 50 anni dalla chiusura della miniera (1964), si avverte ancora il tanfo dello zolfo.
Siamo poi risaliti fino al Pozzo Vittoria, il gigantesco ascensore a carrucole dal quale i minatori discendevano nelle profondità della miniera, anche a 700 metri.
Da qui, abbiamo raggiunto attraverso un sentiero, le vasche, delle enormi cisterne che al tempo della miniera contenevano l’acqua necessaria per fronteggiare eventuali incendi che potevano purtroppo svilupparsi dentro le gallerie.
In questo periodo i campi e i greppi erano tutta una distesa di fiori: gialli, viola, porpora, bianchi. Un tappeto sognante, una distesa senza soluzione di continuità che anticipa il panorama delle creste appenniniche del versante verso il Savio (il Monte Fumaiolo, le colline sopra Sarsina, i monti Toscani più indietro).
Siamo quindi scesi nel borgo di Montecchio e qui siamo passati davanti alla casa della mia famiglia. I miei nonni l’hanno conservata e dopo la loro morte, l’abbiamo ristrutturata, così possiamo trascorrere dei weekend o delle settimane estive, all’insegna del silenzio e del fresco che regnano quassù.
Siamo poi scesi giù, verso quel boschetto che io ho sempre adorato, dove da piccola mia nonna mi portava a raccogliere le more; dove allora c’era il limite alla nostra passeggiata, proprio in corrispondenza di quei rovi. Invece con Ido, Fernando e gli altri perticaresi ho avuto il privilegio già in altre occasioni, di andare oltre, verso quella che era la mia curiosità di bambina.
Le cose vanno aspettate, assaporate, desiderate… e un giorno, per magia accadono. E a Perticara a me ne sono capitate: luoghi visti dalla finestra per anni e finalmente raggiunti durante queste piacevoli escursioni. Alcuni li ho riconosciuti proprio quando vi ero di fianco, e la sorpresa era ancora più grande, emozionante.
Il nostro giro è proseguito scendendo e scendendo ancora, nei campi dei Fondelli, fino a ritrovarci in un piacevole boschetto di piante basse, deliziati da un profumo suadente: le ginestre, le acacie, l’esplosione della primavera che va incontro alla vicina estate. Ci si rintempra anche così, con questi piccoli piaceri sensoriali.
E di nuovo in cammino, sempre più giù, fino al primo guado del torrente Fanante, un affluente di destra del fiume Savio. I due fiumi si incontrano nei pressi di Sarsina, dopo che il Fanante ha già accolto più a monte, vicino a S. Agata Feltria, le acque del rio Marecchiola.
Il guado è agevole, sui sassi e anche con il piede immerso in qualche centimetro di acqua.
E qui siamo in un bosco verde, più fresco. La giornata non è limpida, il sole c’è, ma è offuscato da nubi cariche di afa. Si suda, ci si affanna, si gusta veramente la fatica di camminare e arrivare ad una meta prefissata. Il percorso è bello anche per questo.
Risaliamo un po’ il torrente e poi lo riattraversiamo in un altro guado, anch’esso comodo. E ora lo discendiamo, dentro ad un altro bosco e finalmente arriviamo al punto più basso dell’escursione. In un altro guado del Fanante. Qui, 70 anni fa, c’era un ingresso della Miniera, la Discenderia Fanante.
Tutta questa boscaglia, queste piante, questa natura così rigogliosa, all’epoca non c’erano. Le esalazioni e i rifiuti della lavorazione dello zolfo avevano reso questo posto spoglio di qualsiasi vegetazione, ci sono foto che lo testimoniano. Qui arrivavano i camion a caricare il materiale estratto per portarlo su alla fabbrica della Montecatini (dove ora c’è il museo Sulphur), per lavorarlo e ricavarne zolfo puro. C’era un ponte, crollato da ormai dei decenni. Se ne intravede la struttura ancora abbarbicata sull’argine del fiume.
La natura riprende inesorabilmente e velocemente i suoi spazi, quando l’uomo abbandona i manufatti creati in secoli di lavoro.
Rimane comunque il puzzo di zolfo, fuoriesce da quell’anfratto di grotta, è un gas nauseabondo, pungente, irritante per le mucose nasali.
Tutti noi escursionisti andiamo a vedere questo ingresso della miniera. Per riuscire a salire a quel livello, Ido e gli altri hanno predisposto delle corde legate agli alberi. Siamo in una botte di ferro, tutto è organizzato a puntino per non lasciarci sfuggire nulla.
Dopo esserci affacciati con attenzione all’imbocco della miniera, siamo ritornati indietro e ad un certo punto abbiamo preso un sentiero diverso, per risalire verso il paese di Miniera. Ci attendevano altri ruderi appartenenti ai tempi del duro lavoro in miniera: due ponti, una teleferica. E oltre, un altro guado sul Fanante, stavolta in un punto del suo letto talmente largo da non vedere quasi nemmeno l’acqua scorrere sotto i nostri piedi, se non più a valle, dove scaturiva in una piccola cascata che formava una profonda pozza. E in quel punto, la sorpresa: un cespuglio fiorito di rose canine aggrappate ad una roccia, una meraviglia.
E ora, il percorso, almeno per me, diventava duro. Tutta salita, quasi due chilometri, un po’ all’ombra e un po’ sotto al sole, con il sollievo di una leggera brezza primaverile sprigionata dalle acque fresche e cangianti di un altro piccolo torrente da oltrepassare, il Rio Gaggio.
Più su, ecco il borgo di Cà Piermanzi e ultimo strappo per arrivare al Centro Civico di Miniera di Perticara.
In questo ambiente, che un tempo era la scuola del paese, in cui anche mia mamma ha frequentato le scuole elementari negli anni Quaranta, Ido Rinaldi ha strutturato un piccolo museo della storia della miniera e dei suoi luoghi. Al centro della sala campeggia il plastico che rappresenta la vallata da Perticara verso il Savio, con i suoi borghi e i punti di ingresso della miniera (i pozzi). Inoltre, sono indicati anche gli stabilimenti della Società Mineraria Montecatini (gli uffici, il dopolavoro, gli impianti sportivi e ricreativi per i dipendenti). Perticara ha vissuto un periodo d’oro quando la miniera era in piena attività, pressapoco negli anni Venti e Trenta del Ventesimo secolo.
Il nostro giro è quasi al termine. Ritorniamo sulla strada principale, oltrepassiamo la chiesa di Miniera, dedicata a Santa Barbara, protettrice dei minatori e saliamo verso lo Spaccio della Miniera. Sono ormai le 13, è ora di pranzo.
Queste gite sono sempre accompagnate dai pranzi allo Spaccio. E ce n’è da rifocillarsi… soprattutto con le ottime carni di bovino dell’allevamento e con la ricetta speciale di Nino, il cuoco, che prepara il famoso Asado alla brace dello Spaccio.
Ma non è finita.
Al pomeriggio sono previste altre iniziative per questa giornata delle Fattorie Aperte: la visita alle grotte di infossatura del formaggio di fossa di Sergio Fabbri, sul Monte Aquilone di Perticara e la visita gratuita guidata dentro al Museo delle Miniere Sulphur.
Anche se per me questi posti sono come il pane, talmente familiari da infondermi sicurezza e destrezza nel percorrerli ed osservarli, rappresentano comunque qualcosa che richiama le mie radici in modo vivido, intenso. E grazie alla passione delle tante persone che ho conosciuto quassù, posso veramente asserire che la scoperta non ha mai fine, anche il minimo particolare è sempre qualcosa di nuovo, da apprezzare, da amare. In memoria di quanti hanno lavorato e sono periti nelle viscere che dipartivano da questi luoghi.
Chiara Dall’Ara